Le associazioni tra cibo e letteratura hanno generato davvero un numero infinito di operazioni: sono stati scritti molti saggi, sono stati analizzati i testi di poeti e romanzieri antichi e moderni, per dare un nome e un significato alla simbologia del cibo nelle loro parole.
Non vogliamo qui certamente approfondire un così ampio e complesso campo di riflessione, ma ci piace «lanciare» un primo sassolino prendendo in prestito le parole citate da alcuni docenti universitari nel corso di un dibattito televisivo di qualche anno or sono: “Il cibo e la cucina sono delle grandi metafore dell’esistenza, quindi si prestano particolarmente bene a essere incluse in una narrazione dell’esistenza, a rappresentarla in qualche modo” afferma il professor Massimo Montanari, docente di Scienze dell’Alimentazione dell’Università di Bologna.
Una visione così essenziale, così scarna eppure così completa ci colpisce perché si accosta in modo molto empatico al nostro vissuto e al nostro modo di concepire l’intera filiera dell’olio, alimento primario per eccellenza, e le sue declinazioni.

Approfondiamo in questa sede alcuni esempi, scelti tra migliaia, dell’amplissima letteratura del secolo scorso, cercandone volutamente alcuni dei meno citati abitualmente: ci piacciono per la loro profondità e per la valenza metaforica particolarmente significativa.


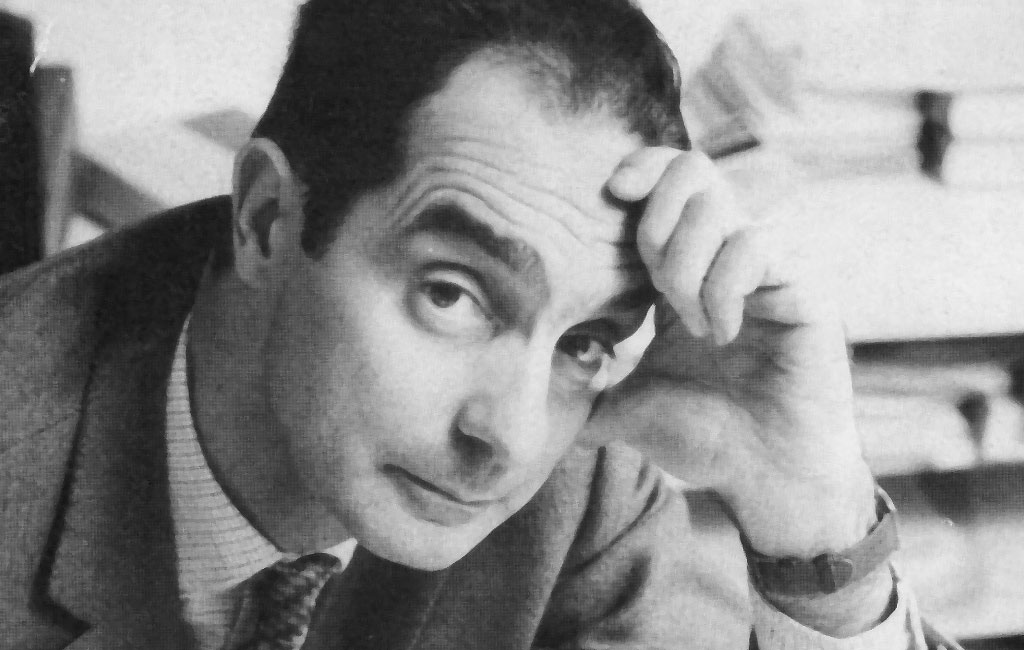

Arrivarono al ristorante “Peppucciu ’u piscaturi”, sulla strata per Fiacca, che erano squasi le deci. Il commissario aveva prenotato un tavolo pirchì quel locale era sempre chino di genti. […] Menu: antipasto di mare (anciovi fatte còciri nel suco di limone e condite con oglio, sali, pepe e prezzemolo; anciovi “sciavurusi” al seme di finocchio; ’nsalata di purpi; fragaglia fritta); primo piatto: spaghetti alla salsa corallina; secondo piatto: aragusta alla marinara (cotta sulla braci viva, condita con oglio, sali e tanticchia di prezzemolo). Si scolaro tri buttiglie di un vino bianco tradimintoso: pariva infatti calare come acqua frisca, ma doppo, ’na volta ch’era dintra, partiva ’n quarta e addrumava il foco.”

